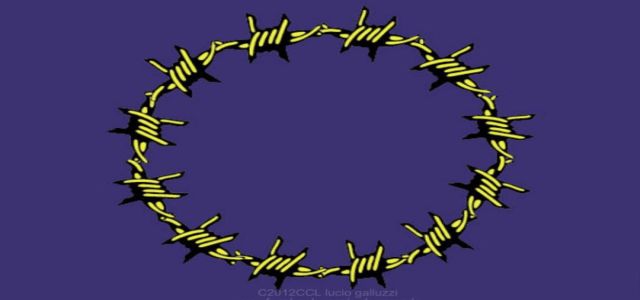
di Alberto Bradanini (*)
I problemi sono sempre politici, mai tecnici. La vita è un divenire, la sola cosa stabile al mondo è il cambiamento. Per gli antichi greci, progenitori del nostro sapere filosofico, la politica era un flusso, un animale instabile i cui spiriti ferini occorreva addomesticare affinché essa potesse servire i bisogni nobili dell’uomo, l’unico ente per il quale il futuro è indeterminato.
L’Unione Europea – lo riconoscono persino gli indecifrabili difensori dei suoi misfatti – presenta ampi spazi di miglioramento, per usare un eufemismo. Essa produceva guai su guai anche prima dello scoppio dell’epidemia. Ora – dopo aver preso coscienza della finta operosità di quelle istituzioni davanti al crollo delle economie post-Covid e aver finalmente scoperto che nei Trattati istitutivi è assente ogni riferimento a un’Europa Federale – la disillusione di molti si va convertendo in un mesto disincanto. Sembra così evaporare l’effimera chimera di un’Europa politicamente unita, creatura immaginifica a lungo sopravvissuta nelle anime semplici degli abitanti al Sud delle Alpi, vittime di un’autoflagellazione sconsiderata, complessi di colpa per sprechi e inefficienze, che seppur innegabili non sono la causa del nostro declino. In Italia, tale fustigazione autoinflitta ha risparmiato alle oligarchie tedesche persino il fastidio di investire sulla tutela di quel marchio contraffatto chiamato Unione (si fa per dire) Europea.
La ragione prima per la quale uno Stato Europeo degno di tal nome non vedrà mai la luce è l’assenza del demos, vale a dire di un popolo europeo, la cui linfa insostituibile – se fosse esistita – si sarebbe da tempo mobilitata per partorirlo. Parliamo di quei tratti costitutivi, di quel sentimento di appartenenza a una medesima nazione che nasce dalle comuni sofferenze nella storia, dalla lingua, la cultura, le sensibilità sedimentate nei secoli, che avrebbero portato all’impegno e alla disponibilità a condividere lo stesso destino. In Europa, questo sentimento, tout simplement, non esiste – non è un caso dunque che di tale orizzonte non vi sia menzione alcuna nei Trattati di Roma, di Maastricht o di Lisbona – e prima ce ne facciamo una ragione, prima potremo iniziare a disegnare un avvenire di crescita economica e culturale su basi diversi, non certo avversative nei riguardi dei paesi europei, ma non più di umiliante e distruttiva sottomissione. È appena il caso di rilevare che tale nuova prospettiva verrebbe centrata su una genuina cooperazione e sarebbe estranea a qualsivoglia concezione di stampo nazionalista, la quale è come noto basata sul perseguimento dei propri interessi contro quelli legittimi delle altre nazioni. Il riconoscimento della storia e degli interessi comuni in Europa avverrebbe su basi di parità, e le decisioni non sarebbero adottate da alcuni (il cosiddetto accordo Merkel-Macron sul fondo di ricostruzione post-Covid è stato l’ultimo di tali mortificanti paradigmi) e poi agli altri comunicate affinché vi diano corso. Un catalogo di umiliazioni questo al quale il nostro ceto dirigente sembra patologicamente assuefatto, senza che gli italiani ne abbiano tratto le dovute conclusioni.
Viene a mente in proposito la purezza rivoluzionaria del fanciullo di Andersen. In quella favola geniale, il Re, informato della scoperta del bambino e pur consapevole del ridicolo nel quale i due truffatori lo avevano precipitato, invece di interrompere all’istante il corteo e rivestirsi, decide di sostenere l’impianto menzognero fino al termine della processione. La magistrale metafora conclusiva è come la punta del coltello nella piaga del nostro tempo. Non la vergogna e nemmeno il ridicolo spinge il Re a porre fine alla farsa. Il popolo sbigottito non capisce la ragione di sostenere l’inganno ora che tutti sanno, eppure il corteo non si ferma. Questo aspetto della fiaba descrive una cosa banale e insieme profonda: la spinta al cambiamento non verrà mai dal palazzo reale. Nessuno si spoglia dei suoi privilegi a meno che non vi sia costretto. E tra questi, il più prepotente è forse quello di voler imporre la propria verità come fosse quella di tutti.
Fuori di metafora, è incontrovertibile – tranne che agli occhi dei negatori di verità in servizio permanente effettivo, molti dei quali governano o hanno nel tempo governato il nostro Paese – che la nostra prima e basilare urgenza deve individuarsi nel recupero della sovranità costituzionale democratica, della cui assenza, curiosamente, i nostri rappresentanti politici non paiono consapevoli.
La cosiddetta Unione Europea (Ue) – alla quale sono state consegnate le chiavi del benessere e del futuro del Paese – è un docile strumento nelle mani dell’oligarchia tedesco-centrica iper-nazionalista, altro che i nostri immaginari sovranisti all’amatriciana, i quali apprezzano i piaceri dell’eloquenza, ma fuggono atterriti davanti alle incertezze del passaggio all’azione. Non cessa di sorprendere l’assuefazione del sistema Italia al deficit democratico dell’Ue, che unita all’analfabetismo economico del nostro ceto dirigente ha trasferito cruciali prerogative costituzionali alla tecnocrazia europea prona alle élite finanziarie sovranazionali. In Italia, queste scelte fondamentali sono state adottate senza un equo dibattito in Parlamento, nel paese e sui media: i grandi giornali e le TV nazionali sono infatti crudeli strumenti della macchina del consenso. La moneta comune è dunque figlia legittima del deficit democratico nel processo di costruzione (si fa per dire) europeo.
La politica è stata privata della sua sovranità, poiché le grandi scelte vengono adottate altrove. Le élite finanziarie si radunano in privato e da lì dettano l’agenda agli esecutori nazionali, ormai depauperati del potere di un tempo. Coloro che oppongono resistenza vengono rinchiusi nel giardino dell’utopia o persino lasciati liberi di agitarsi, nel rispetto di un pluralismo di facciata, e di avanzare richieste che non verranno mai accolte, mentre il popolo è silenziato con l’implicita minaccia che potrebbe andar peggio. Nulla, dunque, deve cambiare.
Le aspettative odierne sono decrescenti. Le idealità di un mondo migliore sono sepolte nell’esegesi a senso unico delle tragedie del XX secolo. Occorre essere responsabili, perché non c’è alternativa allo status quo, anche se questo frantuma l’avvenire, distrugge il benessere e volge lo sguardo altrove davanti alle ingiustizie del mondo.
Governi eticamente assopiti e politicamente sprovveduti chiudono gli occhi davanti al saccheggio economico e alla colonizzazione. I dati che mostrano il trentennale tracollo dell’Italia – che nel 1990, regnante la gloriosa lira, era diventata la quinta economia e la quarta manifattura mondiale – sono fruibili ovunque, basta sfogliarli. Misteriosamente, i nostri politici non leggono. Gli italiani sopravvissuti conservano tuttavia viva memoria dell’elevato potere d’acquisto dei salari negli anni ’80 e ’90 del secolo scorso. Nei decenni 1945-80 il mondo del lavoro aveva raggiunto traguardi straordinari, un formidabile recupero di ricchezza ai danni della rendita e del profitto. Quel percorso aveva consentito l’edificazione di un’estesa base sociale, lavoro stabile, investimenti in infrastrutture fisiche e immateriali, assistenza pubblica, un sistema sanitario che con le sue lacune era tra i migliori al mondo. Tra l’altro, la sua graduale destrutturazione – dovuta ai tagli della spesa pubblica, imposti dai padroni della moneta europea – è stata una delle cause che ha impedito di salvare migliaia di connazionali colpiti dall’epidemia.
Da quando nel 1971 Richard Nixon mise fine alla convertibilità del dollaro in oro, nei paesi politicamente indipendenti, l’emissione di moneta avviene per decreto governativo (e per tale ragione chiamata fiat money), premendo un semplice tasto di un computer. Potrà apparire strano a un cittadino profano di economia, eppure è così.
L’eurozona è un progetto destinato al fallimento, è solo questione di tempo, come da anni affermano autorevoli economisti e premi Nobel dell’Economia – dal neoliberista Milton Friedman ai keynesiani Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Amartya Sen e altri – secondo i quali costringere paesi diversi ad adottare la stessa moneta agganciandola a un cambio fisso avrebbe portato al disastro. In verità, poiché i politici fingono di sapere quello che ignorano e di ignorare quello che sanno, ne deduciamo che non leggano libri, ma solo giornali, soprattutto di parte. Sottomessi psicologicamente prima ancora che culturalmente alle seduzioni del potere finanziario e tecnocratico ultra-nazionale, essi sono privi di energia etica per disegnare un futuro che non sia un esiziale galleggiamento verso la deriva.
La miccia della detonazione della moneta comune potrebbe essere innescata dai paesi saccheggiati in rivolta, oppure meno probabilmente dagli stessi paesi saccheggiatori, qualora questi non vi trovassero ulteriore convenienza. I profeti, diranno alcuni lettori, esistono solo nella Bibbia. Eppure, la logica dei numeri primi – quando tra pochi mesi il debito salirà al 160% sul Pil – porta inesorabilmente verso l’avverarsi di tale profezia, se per disporre di un bene che potrebbe produrre a gratis, la moneta a punto, lo Stato deve rivolgersi alla speculazione, pagando un interesse illecito. Le condizioni del Paese al momento dello scoppio della mina determineranno l’intensità della sofferenza. Nel vuoto di adeguata preparazione, i dolori potrebbero essere acuti, minacciando persino la stabilità sociale. Poiché l’eventuale uscita dall’eurozona potrebbe non essere una nostra decisione, è auspicabile che il governo, con lo sguardo alla Costituzione, prenda in seria considerazione tale ipotesi, approntando, con la massima discrezione, ogni accorgimento a tutela degli interessi del Paese in caso di ritorno alla sovranità monetaria.
Ora, accantonando tale ipotesi, tutt’altro che estrema del resto, il governo ha sin d’ora la possibilità di fare la cosa giusta, rifornendo il Paese della liquidità di cui ha bisogno, mettendo in opera le opzioni elaborate da eminenti economisti e immediatamente praticabili: rafforzamento del sistema di banche pubbliche, ed emissione di CCF (certificati di credito/compensazione fiscale) e di biglietti di stato a corso legale solo in Italia (provvedimenti questi che sarebbero legittimi anche per i funesti Trattati Ue). Resta indecifrabile la ragione dell’inerzia del governo, del mondo delle imprese, dell’informazione e via dicendo. Democrazia significa partecipazione alle decisioni, nelle forme della legge certo, eppure gli spazi sono tanti. Non basta votare ogni lustro.
In Italia, il discorso del padrone è ingessato sull’analisi dei frammenti – i pretesi aiuti Ue a sei zeri ricordano le cifre fantastiche nei fumetti della nostra infanzia – mentre anche incalliti miscredenti prendono atto che l’impalcatura euronica è fondata solo su interessi nazionali e rapporti di forza. Sebbene l’Italia sia uno storico contributore netto al bilancio Ue (negli ultimi sette anni il saldo negativo ha raggiunto i 38 miliardi di euro), è ormai chiaro che Fondi di Riconversione, Mes, Sure e altre ipotetiche fonti si tradurranno tutti in aumento del debito, salvo forse qualche briciola che sempre cade dalla mensa imbandita. Inoltre, cesseranno presto anche gli acquisti indiretti di debito pubblico da parte della Bce, in assenza dei quali l’eurozona sarebbe già esplosa, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale tedesca.
Mentre i paesi proprietari della moneta, vale a dire 194 meno 19 (le nazioni appartenenti all’eurozona) – che gli antisovranisti dovrebbero tacciare di sovranismo (termine strumentalmente associato a nazionalismo, il quale dovrebbe applicarsi solo alla degenerazione del concetto di nazione, non certo alla legittima tutela di quest’ultima) se applicassero anche ad essi la loro abusata etichettatura – sono in grado di emettere tutta la quantità di moneta necessaria a creare lavoro e sostenere l’economia, l’Italia e gli altri paesi euro-sudditi possono far affidamento solo sul mercato. Si tratta di una deformazione che intacca l’essenza costitutiva della statualità, sulla quale i nostri dirigenti – passati e presenti – tendono garbatamente a glissare.
Appare di banale evidenza che la democrazia può esistere solo all’interno dei confini dello stato nazionale, dove solo può nascere il demos di un popolo.
Coloro che hanno edificato un sistema che impone allo Stato, da tempi immemorabili Signore della Moneta, di rivolgersi alla speculazione privata per vivere e prosperare hanno commesso un crimine insieme politico, sociale e razionale. Se si può perdonare l’errore, non è tuttavia consentito sorvolare sulla sua fissazione patologica, alla luce delle tragedie che ne derivano.
La fiducia sprovveduta in una creatura di fantasia non rende giustizia nemmeno ai paesi dominanti. Attendersi dalla Germania il soccorso ai nostri guai equivale a deformare illegittimamente i rapporti politici e giuridici sottoscritti nelle migliaia di documenti sottoscritti in cinquant’anni di percorso istitutivo dell’Ue. In essi infatti non si troverebbe nemmeno una virgola da cui desumere l’ombra di un impegno a condividere un comune destino politico. Solo in una Comunità intenzionata a costruire insieme il proprio futuro (un’Europa Federale o qualcosa di simile), potrebbe essere reclamata l’applicazione del principio di mutuo soccorso. Il pensiero nordico – rebus sic stantibus – è dunque lineare: cari italiani, secondo quale singolare percorso cerebrale siete giunti alla conclusione che abbiamo mai inteso costruire qualcosa come gli Stati Uniti d’Europa? Sin dall’inizio l’eurozona è stata una costruzione tecnica, che del resto funziona piuttosto bene. La moneta comune è debole per noi e ci consente di finanziarci a costi negativi, accumulando avanzi commerciali strepitosi, e troppo forte per voi, impedendovi di farci concorrenza, cosicché ingabbiati nei cambi fissi non potete ricorrere alle insidiose svalutazioni competitive di un tempo. Se provate a cambiare i Trattati, sappiate che è necessaria l’unanimità. Se poi siete in grado di immaginare altre alternative, accomodatevi pure. Punto.
La macchina pubblica italiana orienta invece il dibattito sul quantum dell’obolo che l’Italia potrebbe spuntare in questo passaggio cruciale. Un’elemosina adeguata consoliderebbe il governo, proteggendo insieme il salvadanaio tedesco e quelli dei paesi satelliti, che si riempiono sempre più attraverso un sistema monetario distorto e insostenibile. La discussione evita così di affrontare i fondamentali, abbracciando il discorso del padrone (mutatis mutandi, la Thatcher ne aveva fatto il suo dogma): there is no alternative, a questo destino non si può sfuggire.
Il ceto dirigente italiano – a prescindere dalla sua collocazione sull’emiciclo – incorpora nel subconscio l’ideologia della fissità e quella dell’inazione ontologica. La fine della parola è l’applauso, la sfera del senso è assorbita dall’assenso. Il grande sinologo britannico del secolo scorso, Joseph Needham, affermava che l’orgoglio si accompagna all’ignoranza, mentre l’umiltà spinge a riconoscere gli errori, e da questi imparare. Alcuni potrebbero sorprendersi che l’infertilità ideologica immobilista pervada nella stessa misura le menti dei dirigenti progressisti e di quelli conservatori. Ma la risposta è banale, il pensiero unico liberista e sovranazionalista, contro lo spirito costituzionale della legittima sovranità istituzionale e monetaria, ha da tempo tragicamente conquistato (forse la data tragica è il 1989) tutti gli spazi del palcoscenico politico.
Ecco quindi che i (non) decisori politici si possono suddividere in due categorie. In prima fila troviamo coloro che esprimono fiducia fideistica nella chimera degli stati federali europei e che giustificano i guai odierni all’insegna del traguardo finale, che un giorno (magari nella profondità keynesiana) ci ripagherà delle tante sofferenze di oggi.
Vengono quindi coloro che respirano l’angoscia paralizzante di dover decidere, di aprirsi sull’ignoto, di abbandonare la rassicurante certezza dello status quo. Il passaggio all’azione espone al rischio della sconfitta, alla cacciata dal paradiso di carriere, prebende e tappeti rossi, del disagio e dell’inquietudine, della solitudine e della sconfessione. La resistenza al cambiamento è dunque legata alla caratura psicologica degli attori in campo, non all’altezza della crudeltà dei tempi, e ancor meno dei privilegi di cui godono.
I cinici affermano che non c’è da temere: l’implosione dell’euro verrà impedita dal paese che ne trae maggior beneficio, la Germania. Una logica spietata, che rischia di corrispondere al vero, perpetuando così l’asservimento politico ed economico dell’Italia, in attesa del passaggio successivo, la sua definitiva colonizzazione. Amen.
(*) Alberto Bradanini è un ex-diplomatico. Tra gli incarichi ricoperti, è stato Ambasciatore d’Italia a Teheran (2008-2012) e a Pechino (2013-2015). È attualmente Presidente del Centro Studi sulla Cina Contemporanea.
Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo con i tuoi amici
Segui il blog e abbonati alla nostra rivista Sovranità Popolare

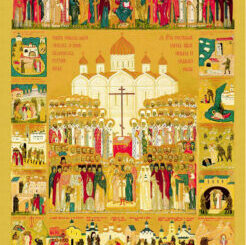


Commenta per primo